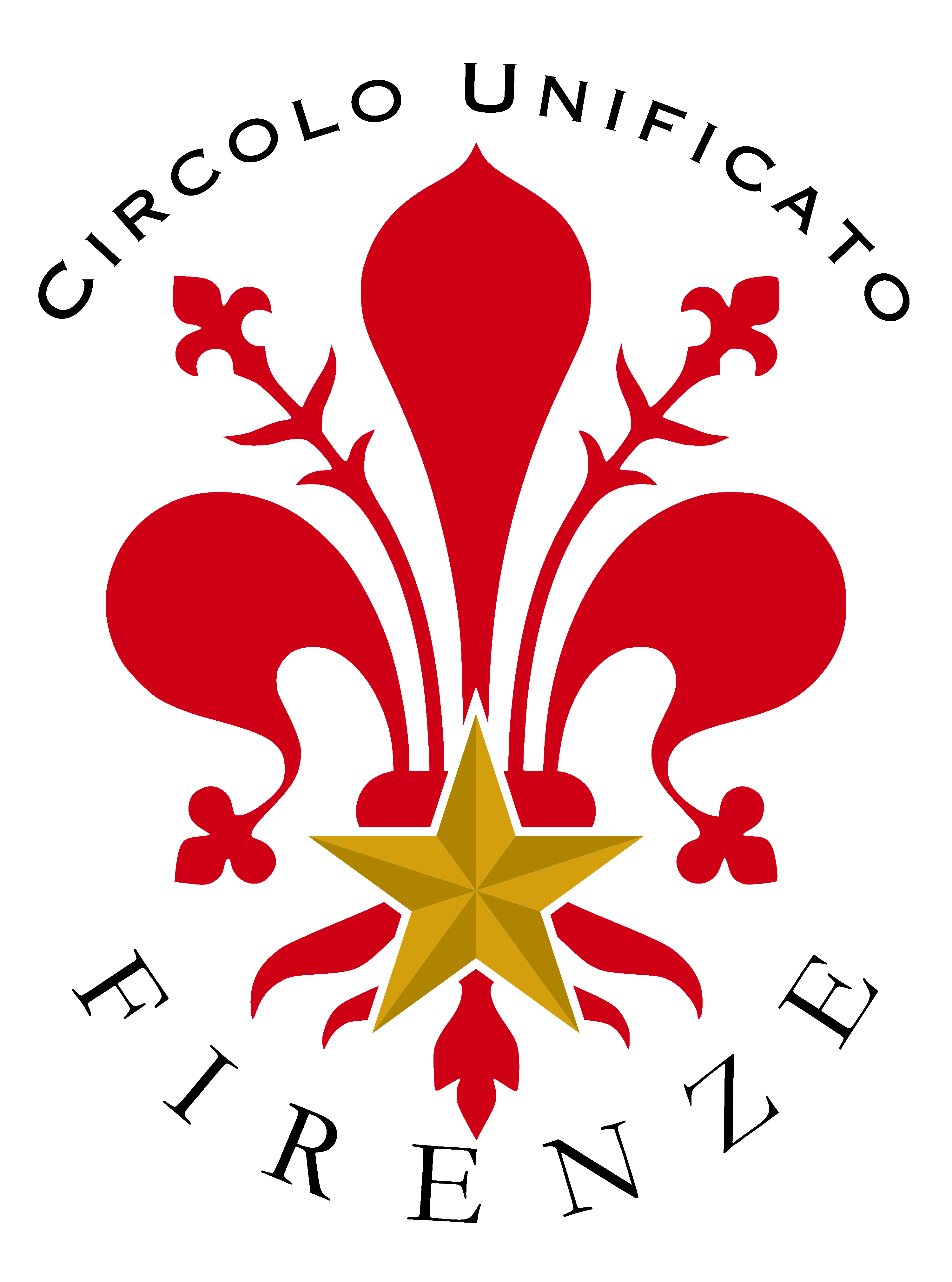Storia del Complesso di San Jacopo a Ripoli
Il Complesso di San Jacopo a Ripoli sorge a Firenze, lungo via della Scala, in un’area che nel XIII secolo era ancora in parte paludosa, bonificata dai frati della Sacca. In questa zona, alla fine del Duecento, fu fondato un monastero domenicano femminile noto come San Jacopo e San Domenico di Ripoli, in riferimento alla provenienza delle religiose dal Pian di Ripoli.
Il complesso si distinse presto per la sua rilevanza culturale: nel 1472, Bernardo Cennini vi individuò la sede della prima stamperia fiorentina a caratteri mobili, un primato significativo per la storia della tipografia italiana. Secondo Vincenzio Fineschi nel suo trattato del 1781 Notizie storiche sopra la stamperia di Ripoli, e confermato da Pietro Bologna nel 1893, tra il 1476 e il 1484 il convento ospitò una tipografia attiva, diretta dai frati Domenico da Pistoia e Pietro da Pisa, con l’aiuto delle stesse monache. In quegli anni furono stampate circa 94 edizioni, sia in latino che in volgare, tra cui la Grammatica di Elio Donato. Questo episodio rese il monastero un vero e proprio centro di diffusione del sapere nel Quattrocento.
Durante il Cinquecento il complesso subì vari ampliamenti, e alla fine del secolo fu oggetto di un importante intervento di ristrutturazione del chiostro grande. Un cambiamento radicale avvenne nel 1785, quando il granduca Pietro Leopoldo dispose la trasformazione del monastero in conservatorio per l’educazione delle giovani (ziettelle), come descritto da Marco Lastri nel suo Osservatore Fiorentino. L’edificio fu quasi interamente ricostruito nel 1787 su progetto dell’architetto Giuseppe Salvetti, con una nuova impostazione strutturale ed estetica più adatta alla nuova funzione.
Nel 1794, con il trasferimento delle domenicane nel monastero di San Pietro a Monticelli, la gestione del conservatorio passò alle Montalve, che lo ressero fino al 1886, prima di spostarsi alla Quiete. Da quel momento, l’immobile fu indemaniato e adibito a caserma per il Terzo Reggimento Genio, determinando notevoli trasformazioni: la chiesa venne spogliata delle sue opere d’arte, trasferite dalle Montalve, e fu riconvertita in magazzino per il vestiario militare.
All’inizio del Novecento il complesso era noto come Caserma Vittorio Emanuele, come riportato nelle mappe cittadine. Intorno al 1910, nuovi corpi edilizi furono costruiti lungo via della Scala e via Jacopo da Diacceto, mentre l’area dove oggi sorge la caserma Simoni risultava ancora libera. Durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, il complesso subì ulteriori danni strutturali e fu temporaneamente adibito ad alloggi per profughi.
Nel 1966, l’architetto Adolfo Pagani progettò ampliamenti e nuove ristrutturazioni. Oggi, il complesso si presenta come una lunga sequenza di fabbricati lungo la strada, in parte costruiti alla fine dell’Ottocento, con facciate architettonicamente modeste, pensate per affacciarsi sui cortili interni piuttosto che verso l’esterno. Un raro esempio del lavoro originale di Salvetti è ancora visibile nel cancello monumentale al civico 68, in asse con il prospetto lorenese, recentemente restaurato e affacciato su un giardino.
Su questo stesso prospetto si trova una lapide commemorativa che celebra l’intervento del Granduca Pietro Leopoldo e la conclusione dei lavori nel 1787.
Infine, secondo lo studioso Angiolo Pucci (I giardini di Firenze, 2017), nel corso del Novecento si registrò una progressiva riduzione degli orti e dei giardini annessi al complesso, in parte ancora esistenti e descritti tra gli anni Venti e Trenta.
Il Circolo Unificato dell’Esercito di Firenze
Il Circolo Unificato dell’Esercito di Firenze, noto anche come Foresteria di Firenze, è una storica istituzione situata nel cuore della città. Fondato per offrire un luogo di ritrovo e relax agli Ufficiali della Forza Armata Esercito, il Circolo si è evoluto nel corso degli anni mantenendo il suo spirito originale di comunità e servizio.
Il Circolo combina l’eleganza architettonica con la tradizione militare, rendendolo un punto di riferimento per gli appartenenti all’Esercito e le loro famiglie. Oltre a servire come centro sociale e culturale, il Circolo organizza eventi, conferenze e incontri che arricchiscono la vita sociale dei suoi membri.
Nel corso degli anni, il Circolo Unificato ha aperto le sue porte anche alla comunità civile, promuovendo iniziative che rafforzano il legame tra l’esercito e la società civile. Questa apertura ha contribuito a fare del Circolo un luogo d’incontro privilegiato per scambi culturali e sociali, mantenendo sempre un’atmosfera di esclusività e rispetto delle tradizioni.